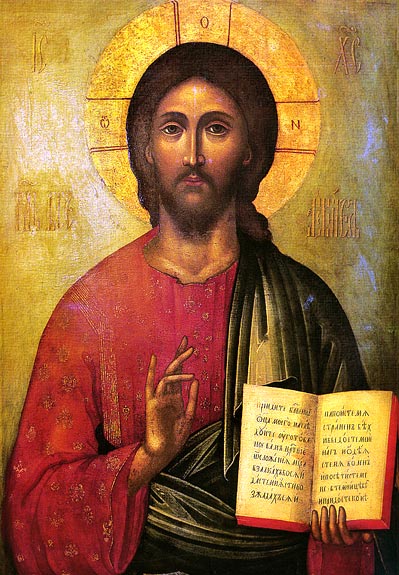|
CONGREGAZIONE
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE |
|
|
|
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
RISPOSTE A QUESITI
RIGUARDANTI ALCUNI ASPETTI |
|
|
|
Introduzione Il Concilio Vaticano II, con la Costituzione dogmatica Lumen gentium e con i Decreti sull'Ecumenismo (Unitatis redintegratio) e sulle Chiese orientali (Orientalium Ecclesiarum), ha contribuito in modo determinante ad una comprensione più profonda dell'ecclesiologia cattolica. Al riguardo anche i Sommi Pontefici hanno voluto offrire approfondimenti e orientamenti per la prassi: Paolo VI nella Lettera Enciclica Ecclesiam suam (1964) e Giovanni Paolo II nella Lettera Enciclica Ut unum sint (1995). Il conseguente impegno dei teologi, volto ad illustrare sempre meglio i diversi aspetti dell'ecclesiologia, ha dato luogo al fiorire di un'ampia letteratura in proposito. La tematica si è infatti rivelata di grande fecondità, ma talvolta ha anche avuto bisogno di puntualizzazioni e di richiami, come la Dichiarazione Mysterium Ecclesiae (1973), la Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica Communionis notio (1992) e la Dichiarazione Dominus Iesus (2000), tutte pubblicate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. La vastità dell'argomento e la novità di molti temi continuano a provocare la riflessione teologica, offrendo sempre nuovi contributi non sempre immuni da interpretazioni errate che suscitano perplessità e dubbi, alcuni dei quali sono stati sottoposti all'attenzione della Congregazione per la Dottrina della Fede. Essa, presupponendo l'insegnamento globale della dottrina cattolica sulla Chiesa, intende rispondervi precisando il significato autentico di talune espressioni ecclesiologiche magisteriali, che nel dibattito teologico rischiano di essere fraintese. RISPOSTE AI QUESITI Primo quesito: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha forse cambiato la precedente dottrina sulla Chiesa ? Risposta: Il Concilio Ecumenico Vaticano II né ha voluto cambiare né di fatto ha cambiato tale dottrina, ma ha voluto solo svilupparla, approfondirla ed esporla più ampiamente. Proprio questo affermò con estrema chiarezza Giovanni XXIII all’inizio del Concilio[1]. Paolo VI lo ribadì[2] e così si espresse nell’atto di promulgazione della Costituzione Lumen gentium: "E migliore commento sembra non potersi fare che dicendo che questa promulgazione nulla veramente cambia della dottrina tradizionale. Ciò che Cristo volle, vogliamo noi pure. Ciò che era, resta. Ciò che la Chiesa per secoli insegnò, noi insegniamo parimenti. Soltanto ciò che era semplicemente vissuto, ora è espresso; ciò che era incerto, è chiarito; ciò che era meditato, discusso, e in parte controverso, ora giunge a serena formulazione"[3]. I Vescovi ripetutamente manifestarono e vollero attuare questa intenzione[4]. Secondo quesito: Come deve essere intesa l’affermazione secondo cui la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica ? Risposta: Cristo "ha costituito sulla terra" un’unica Chiesa e l’ha istituita come "comunità visibile e spirituale"[5], che fin dalla sua origine e nel corso della storia sempre esiste ed esisterà, e nella quale soltanto sono rimasti e rimarranno tutti gli elementi da Cristo stesso istituiti[6]. "Questa è l’unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica […]. Questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal Successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui"[7]. Nella Costituzione dogmatica Lumen gentium 8 la sussistenza è questa perenne continuità storica e la permanenza di tutti gli elementi istituiti da Cristo nella Chiesa cattolica[8], nella quale concretamente si trova la Chiesa di Cristo su questa terra. Secondo la dottrina cattolica, mentre si può rettamente affermare che la Chiesa di Cristo è presente e operante nelle Chiese e nelle Comunità ecclesiali non ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica grazie agli elementi di santificazione e di verità che sono presenti in esse[9], la parola "sussiste", invece, può essere attribuita esclusivamente alla sola Chiesa cattolica, poiché si riferisce appunto alla nota dell’unità professata nei simboli della fede (Credo…la Chiesa "una"); e questa Chiesa "una" sussiste nella Chiesa cattolica[10]. Terzo quesito: Perché viene adoperata l’espressione "sussiste nella" e non semplicemente la forma verbale "è" ? Risposta: L’uso di questa espressione, che indica la piena identità della Chiesa di Cristo con la Chiesa cattolica, non cambia la dottrina sulla Chiesa; trova, tuttavia, la sua vera motivazione nel fatto che esprime più chiaramente come al di fuori della sua compagine si trovino "numerosi elementi di santificazione e di verità", "che in quanto doni propri della Chiesa di Cristo spingono all’unità cattolica"[11]. "Perciò le stesse Chiese e Comunità separate, quantunque crediamo che hanno delle carenze, nel mistero della salvezza non sono affatto spoglie di significato e di peso. Infatti lo Spirito di Cristo non ricusa di servirsi di esse come di strumenti di salvezza, il cui valore deriva dalla stessa pienezza della grazia e della verità, che è stata affidata alla Chiesa cattolica"[12]. Quarto quesito: Perché il Concilio Ecumenico Vaticano II attribuisce il nome di "Chiese" alle Chiese orientali separate dalla piena comunione con la Chiesa cattolica ? Risposta: Il Concilio ha voluto accettare l’uso tradizionale del nome. "Siccome poi quelle Chiese, quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il Sacerdozio e l’Eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora uniti con noi da strettissimi vincoli"[13], meritano il titolo di "Chiese particolari o locali"[14], e sono chiamate Chiese sorelle delle Chiese particolari cattoliche[15]. "Perciò per la celebrazione dell’Eucaristia del Signore in queste singole Chiese, la Chiesa di Dio è edificata e cresce"[16]. Siccome, però, la comunione con la Chiesa cattolica, il cui Capo visibile è il Vescovo di Roma e Successore di Pietro, non è un qualche complemento esterno alla Chiesa particolare, ma uno dei suoi principi costitutivi interni, la condizione di Chiesa particolare, di cui godono quelle venerabili Comunità cristiane, risente tuttavia di una carenza[17]. D’altra parte l’universalità propria della Chiesa, governata dal Successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui, a causa della divisione dei cristiani, trova un ostacolo per la sua piena realizzazione nella storia[18]. Quinto quesito: Perché i testi del Concilio e del Magistero successivo non attribuiscono il titolo di "Chiesa" alle Comunità cristiane nate dalla Riforma del 16° secolo ? Risposta: Perché, secondo la dottrina cattolica, queste Comunità non hanno la successione apostolica nel sacramento dell’Ordine, e perciò sono prive di un elemento costitutivo essenziale dell’essere Chiesa. Le suddette Comunità ecclesiali, che, specialmente a causa della mancanza del sacerdozio ministeriale, non hanno conservato la genuina e integra sostanza del Mistero eucaristico[19], non possono, secondo la dottrina cattolica, essere chiamate "Chiese" in senso proprio[20]. Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha approvato e confermato queste Risposte, decise nella sessione ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione. Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 29 giugno 2007, nella solennità dei Ss. Pietro e Paolo, Apostoli.
William Cardinale Levada
Angelo Amato, S.D.B.
|
|
|
|
[2] Cf. PAOLO VI, Allocuzione del 29 settembre 1963: AAS 55 [1963] 847-852. [3] PAOLO VI, Allocuzione del 21 novembre 1964: AAS 56 [1964] 1009-1010 (trad. it. in: L’Osservatore Romano, 22 novembre 1964, 3). [4] Il Concilio ha voluto esprimere l’identità della Chiesa di Cristo con la Chiesa Cattolica. Ciò si trova nelle discussioni sul Decreto Unitatis redintegratio. Lo Schema del Decreto fu proposto in Aula il 23. 9. 1964 con una Relatio (Act Syn III/II 296-344). Ai modi inviati dai vescovi nei mesi seguenti il Segretariato per l’Unità dei Cristiani risponde il 10.11.1964 (Act Syn III/VII 11-49). Da questa Expensio modorum si riportano quattro testi concernenti la prima risposta. A) [In Nr. 1 (Prooemium) Schema Decreti: Act Syn III/II 296, 3-6] "Pag. 5, lin. 3-6: Videtur etiam Ecclesiam catholicam inter illas Communiones comprehendi, quod falsum esset. R(espondetur): Hic tantum factum, prout ab omnibus conspicitur, describendum est. Postea clare affirmatur solam Ecclesiam catholicam esse veram Ecclesiam Christi" (Act Syn III/VII 12). B) [In Caput I in genere: Act Syn III/II 297-301] "4 - Expressius dicatur unam solam esse veram Ecclesiam Christi; hanc esse Catholicam Apostolicam Romanam; omnes debere inquirere, ut eam cognoscant et ingrediantur ad salutem obtinendam... R(espondetur): In toto textu sufficienter effertur, quod postulatur. Ex altera parte non est tacendum etiam in aliis communitatibus christianis inveniri veritates revelatas et elementa ecclesialia"( Act Syn III/VII 15). Cf. anche ibidem punto 5. C) [In Caput I in genere: Act Syn III/II 296s] "5 - Clarius dicendum esset veram Ecclesiam esse solam Ecclesiam catholicam romanam... R(espondetur): Textus supponit doctrinam in constitutione ‘De Ecclesia’ expositam, ut pag. 5, lin. 24-25 affirmatur" (Act Syn III/VII 15). Quindi la commissione che doveva valutare gli emendamenti al Decreto Unitatis redintegratio esprime con chiarezza l’identità della Chiesa di Cristo e della Chiesa cattolica e la sua unicità, e vede questa dottrina fondata nella Costituzione dogmatica Lumen gentium. D) [In Nr. 2 Schema Decreti: Act Syn III/II 297s] "Pag. 6, lin. 1- 24: Clarius exprimatur unicitas Ecclesiae. Non sufficit inculcare, ut in textu fit, unitatem Ecclesiae. R(espondetur): a) Ex toto textu clare apparet identificatio Ecclesiae Christi cum Ecclesia catholica, quamvis, ut oportet, efferantur elementa ecclesialia aliarum communitatum". "Pag. 7, lin. 5: Ecclesia a successoribus Apostolorum cum Petri successore capite gubernata (cf. novum textum ad pag. 6, lin.33-34) explicite dicitur ‘unicus Dei grex’ et lin. 13 ‘una et unica Dei Ecclesia’ " (Act Syn III/VII). Le due espressioni citate sono quelle di Unitatis redintegratio 2.5 e 3.1. [5] Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 8.1. [6] Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. Unitatis redintegratio, 3.2; 3.4; 3.5; 4.6. [7] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 8.2. [8] Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. Mysterium Ecclesiae, 1.1: AAS 65 [1973] 397; Dich. Dominus Iesus, 16.3: AAS 92 [2000-II] 757-758; Notificazione sul libro di P. Leonardo Boff, OFM, "Chiesa: carisma e potere": AAS 77 [1985] 758-759. [9] Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Ut unum sint, 11.3: AAS 87 [1995-II] 928. [10] Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 8.2. [11] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 8.2. [12] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. Unitatis redintegratio, 3.4. [13] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. Unitatis redintegratio, 15.3; cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. Communionis notio, 17.2: AAS, 85 [1993-II] 848. [14] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. Unitatis redintegratio, 14.1. [15] Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. Unitatis redintegratio, 14.1; GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Ut unum sint, 56 s : AAS 87 [1995-II] 954 s. [16] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. Unitatis redintegratio, 15.1. [17] Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. Communionis notio, 17.3: AAS 85 [1993-II] 849. [18] Cf. ibid. [19] Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. Unitatis redintegratio, 22.3.
[20]
Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. Dominus Iesus,
17.2: AAS 92 [2000-II] 758. |
|
© Copyright 2007 -
Libreria Editrice Vaticana |
HOME chi siamo | liturgia | bibbia | voci dal deserto | immagini & webcam | chiese locali | testi & documenti | pensieri
san francesco & santa chiara | massime eterne | papas pefkis | l'arcivescovo lambruschini | banner exch | links